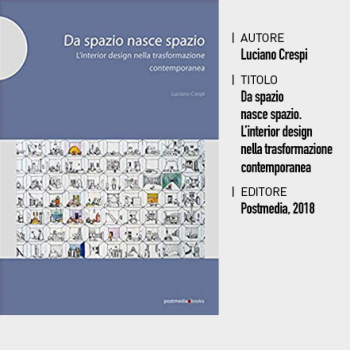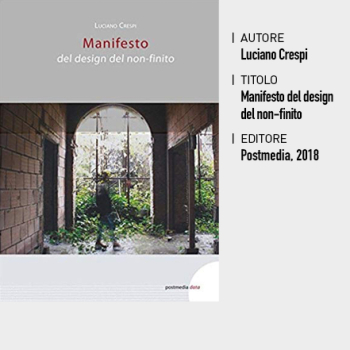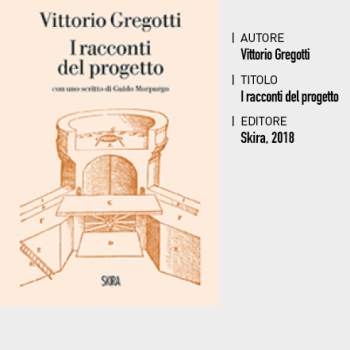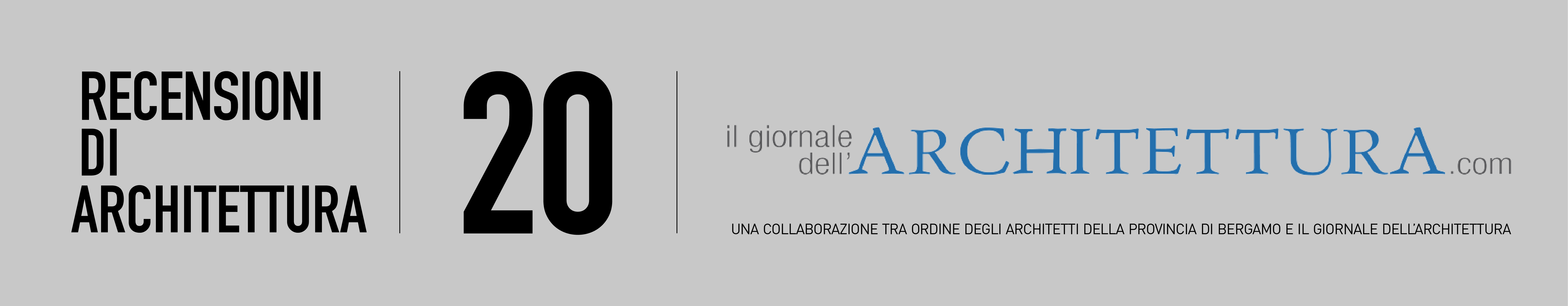
Tema | ARCHITETTURA | Alessandro Colombo – 30 Gennaio 2019 | RdA20
Tre libri di due autori di lungo corso, Luciano Crespi e Vittorio Gregotti, danno speranza alle ragioni del progetto, tra design e architettura.
–
I territori del progetto appaiono oggi lande in-definite nelle quali è difficile trovare una direzione, un segno, un’indicazione, fra le mille esistenti che fra di loro si annullano. Cenni di conforto provengono dalle riflessioni di due autori che si muovono in campi apparentemente lontani.
Preceduto da un testo del 2012, in seconda edizione nel 2018 (Da spazio nasce spazio. L’interior design nella trasformazione contemporanea), Luciano Crespi persevera nella sua riflessione nei territori inesplorati della dimensione del progetto arrivando ad un vero e proprio manifesto (“Manifesto del design del non-finito”) che incentra la sua attenzione sul non finito. L’affascinante categoria dello spazio – trasversale alla storia dell’architettura in ogni epoca e in ogni paese – viene qui indagata nella dimensione del design, per quello che può valere la distinzione, in questo caso specifico, fra le due discipline. Se Da spazio nasce spazio recuperava, non solo nel titolo, la lezione di Munari in Da cosa nasce cosa – proponendo attraverso 26 saggi nuove direzioni per l’attività progettuale verso territori inesplorati ma esplorabili per chi è disposto ad abbandonare i confortevoli confini di design, arte, architettura, musica, pur sempre partendo ed arrivando all’interior design, concepito in modo vasto ed allargato – nel “Manifesto” si rompono gli indugi, se ancora ce ne fossero stati, per individuare nei luoghi che hanno perso la funzione originaria dei veri e propri avanzi, che vengono eletti a rappresentanti delle condizioni di provvisorietà, precarietà, cultura trasversale, proprie del nostro tempo. Sugli avanzi è fondata la poetica del design del non-finito, inteso come attività progettuale fondata “sull’uso giudizioso delle risorse, il ricorso a interventi reversibili, la valorizzazione degli elementi di degrado presenti nei luoghi sui quali si deve operare e non può prescindere dall’elaborazione di nuovi codici estetici, cioè di una estetica dell’avanzo“.
Nell’altra metà del cielo Vittorio Gregotti affida al racconto il messaggio di una vita dedicata all’architettura e alla riflessione su di essa; riflessione che rimane poetica anche nella complessità odierna. Il patrimonio culturale di una pratica che si divide fra arte, tecnica e attività civile non deve e non può essere disperso, deve resistere nei suoi fondamenti disciplinari di fronte alle frenesie commerciali e agli esercizi di stile formali che producono luoghi privi di valore urbanistico, urbano, culturale; in una parola privi di valore architettonico. Contro i luoghi come City Life a Milano – post-architettura sradicata dal contesto, adatta a selfies e a post su instagram per pseudo fotografi a caccia di immagini, vittime del potere finanziario globale e della rivoluzione digitale, più che spazio urbano per cittadini e architetti – bisogna attivamente operare per evitare il declino e il disorientamento. Gregotti lo fa portando all’attenzione generale innanzi tutto la propria esperienza di un quadro storico vissuto in prima persona negli ultimi 60 anni. Lo scopo del volume, con grande cautela ma non senza solide certezze, è “cercare di capire se sia possibile ed utile riflettere sul percorso del progetto di architettura come racconto dei modi di prender forma delle sue intenzionalità”, concentrandosi cioè su come “l’architettura si offra anche come una forma di narrazione dei materiali scelti” proponendo un “frammento di verità altra rispetto alla realtà del presente”. La narrazione della narrazione, potremmo dire, scorre profonda e complessa – come l’autore ci ha abituato a fare in tutti i suoi scritti – e, completata da una riflessione di Guido Morpurgo, si articola in una prima parte ove sono indagate le condizioni dei “frammenti di verità del presente” utilizzando categorie non sempre scontate come il silenzio, le incertezze e le difficoltà, la disgiunzione, ma attraverso il segno e l’intenzionalità, il segno e il disegno, si giunge a “quattro virtù, Precisione-Semplicità-Ordine-Organicità”, che permettono di immergersi in “Architettura, Storia e Narrazione”, in un percorso non semplice ma appagante. Per chi arriva alla fine Gregotti riserva dei “Suggerimenti”, una piccola speranza che afferma che le “ragioni di una concezione della nostra disciplina… debbano essere protagoniste dei nostri progetti”, proponendo una strategia difensiva volta a “ridurre le arbitrarietà, i vaniloqui omnisimbolici, le trovate travestite da ricominciamenti, e di contrastare… l’impero della visibilità commerciale del cliente e dell’autore che domina nei nostri anni le opere dell’architettura…”.
Se si può trarre una conclusione dalla lettura di questi testi è che una speranza progettuale pur sempre esiste e trova le ragioni ed i terreni per non morire con brillante ed insistita perseveranza in ogni epoca storica. Compresa la nostra.
[Data di pubblicazione articolo: 04.04.2017]