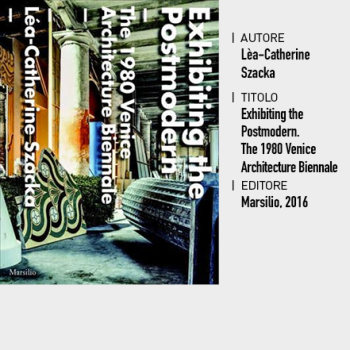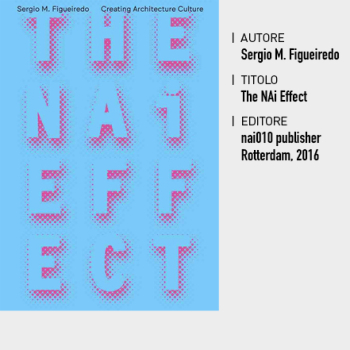Tema | ARCHITETTURA CONTEMPORANEA | Chiara Cuatto – 9 Aprile 2017 | RdA4
Chi c’è dietro al Postmoderno?
–
La lettura della nascita e dello sviluppo del movimento nei libri di Lèa-Catherine Szacka e Sergio M. Figueiredo. Per scoprire l’importanza della rappresentazione e degli eventi culturali.
–
La demarcazione dei periodi storici è affare complicato. Difficilmente il tempo e le correnti hanno un’ora di inizio e una data di scadenza, soprattutto quando si tratta di tendenze ed eventi temporalmente vicini. Nonostante ciò,Exhibiting the Postmodern. The 1980 Venice Architecture Biennale di Lèa-Catherine Szacka, e The NAi Effect di Sergio M. Figueiredo riescono a fornire una narrazione completa del processo storico alle spalle del tanto discusso postmoderno.
I due libri si concentrano su due eventi chiave che hanno segnato una svolta nel panorama culturale e architettonico: la prima Biennale di Architettura di Venezia nel 1980 e il Netherlands Architecture Institute (NAi), nato nel 1985. Mentre nel caso di Szacka il tema centrale è inquadrare la Biennale come punto di svolta nell’affermazione del movimento postmoderno, nel caso di Figueiredo questa questione rimane sullo sfondo di un processo più intricato e concettuale sulle esposizioni di architettura.
Oltre ad uno stile narrativo differente, ma per entrambi chiaro e leggero, le diverse motivazioni che muovono le pubblicazioni influenzano il risultato finale. Nel caso di Figueiredo il libro è una rielaborazione della tesi di dottorato che, con l’obiettivo di spiegare la nascita e lo sviluppo del NAi, ha affrontato un discorso concettuale sul significato degli archivi e delle esposizioni (argomento che in Olanda occupava gran parte dei dibattiti già da parecchi anni) da un punto di vista storico, con inizio nella seconda metà del 1700. Ma la parte più significativa si sovrappone con il periodo trattato da Szacka la quale, nonostante si sia concentrata sul ricco panorama italiano degli anni di piombo, è riuscita a fare la giusta sintesi socio-politica di un periodo movimentato.
Le informazioni chiave per comprendere il cambiamento storico sono presenti in entrambi gli scritti, ma nel caso di Venezia sono meglio inserite nel discorso e collegate tra loro a tessere una complessa ma chiara rete di personaggi ed eventi. Eventi che permettono di tracciare un percorso e capire quelle che Szacka definisce le radici del cambiamento. I tumulti che hanno segnato l’Europa dagli anni ’60 in poi hanno logorato le popolazioni, specialmente quella italiana che, stanca di vivere nel terrore e nell’incertezza, ha prediletto leggerezza e divertimento alla politica e all’attivismo. Per quanto sembri irrilevante, questo passaggio è importante nella definizione di un aspetto cardine del postmoderno che è perdurato fino ad oggi, ovvero l’individualismo. Non è un caso che lo star system nasca in questi anni, marcando il passaggio da grandi tendenze a grandi personaggi; l’emblema della Biennale (con la celeberrima Strada Novissima concepita dal direttore Paolo Portoghesi) era anche l’emblema del cambiamento, una via costituita da firme.
Szacka – riassumendo i valori del postmoderno, «pluralità, importanza del linguaggio, multivalenza, comunicazione di massa, consumismo, simulacro e storicismo» – ricorda anche che, oltre ai contenuti, le modalità di esposizione cambiano radicalmente. Questo principalmente per due motivi: la volontà di distaccarsi dai moderni e in parallelo la necessità d’individuare nuovi modi per comunicare l’architettura. In questo l’analisi fatta da Figueiredo torna utile per capire che le conclusioni e gli esperimenti dei postmoderni non sono nati da zero ma derivano da lunghi dibattiti sul significato delle mostre di architettura e sui problemi legati all’impossibilità di esporre l’oggetto architettonico nella sua totalità. Nel percorso tumultuoso che ha caratterizzato il NAi questo argomento è stato probabilmente il più discusso, creando due fazioni ben distinte tra chi credeva che il museo dovesse solo rappresentare disegni tecnici indipendentemente dalla qualità di rappresentazione (e quindi essere per un pubblico specializzato) e chi invece, spinto dalla voglia di aumentare l’audience e allargare il dibattito, ritenesse più opportuno esporre disegni anche solo per la loro bellezza intrinseca.
Ciò introduce un ulteriore frammento che ruota intorno alla rappresentazione. Entrambi gli autori sottolineano come durante questi anni il disegno (e quindi il processo creativo) sorpassi in termini d’importanza il contenuto (quindi l’edificio). Per la prima volta gli elaborati che si espongono alla Biennale (come anche le opere del NAi) sono prodotti per un mondo governato e fatto per i media, il linguaggio cambia e i risultati si allontanano molto dalle precedenti esposizioni che avevano animato il Movimento moderno. Anche in virtù del fatto che uno degli obiettivi principali di entrambe le istituzioni (e dei postmoderni) era quello di aprirsi ad un pubblico non esperto. Questo necessariamente imponeva soluzioni espositive più coinvolgenti, meno tecniche, portando così all’esaltazione della rappresentazione. Paradossalmente, però, questa apertura al grande pubblico e la possibilità di capire i contenuti delle mostre, secondo la Szacka, fu anche l’inizio della caduta del postmoderno.
Nonostante il movimento sia ufficialmente durato poco ha lasciato segni profondi; e lo si legge chiaramente nella riflessione, affascinante quanto destabilizzante, che viene fatta in merito alla capacità degli eventi culturali – specialmente le esposizioni – d’influenzare la società. Come Figueiredo esprime bene nella parte iniziale del libro, le collezioni d’arte e d’architettura da sempre sono state strumenti di manipolazione ed educazione. Di conseguenza l’architettura ricopre un ruolo ambiguo, essendo contemporaneamente oggetto influenzato e influenzante.
I segni profondi che oggi ancora si colgono sono in parte l’effetto della forza delle esposizioni che le due istituzioni qui analizzate hanno sfruttato al massimo. A livello internazionale, infatti, il postmoderno ha preso piede portato avanti da curatori di musei e direttori di esposizioni (esempio calzante era l’allora direttore del DAM, il museo di architettura tedesco, che prediligeva solo i suoi architetti postmoderni preferiti, dando loro visibilità internazionale). Consapevolmente sono state scelte persone, stili e valori; e tramite le esposizioni tali scelte sono arrivate al grande pubblico, influenzandolo.
Entrambi i libri sono caratterizzati da numerosi dettagli storici che riportano una visione olistica della società, fornendo gli strumenti necessari per capire processi spesso sono raccontati solo nella loro parte più superficiale. Nonostante siano entrambi scritti da architetti e centrati sull’architettura, adottano un linguaggio trasversale, sottolineando l’influenza che eventi sporadici ed apparentemente di nicchia abbiano in realtà delle conseguenze, più o meno profonde, a livello sociale. Come Figueiredo scrive citando il direttore del DAM, «l’architettura non può essere ridotta a struttura, funzione e costi, ma è effettivamente l’espressione culturale della società».
[Data di pubblicazione articolo: 16.10.2017]